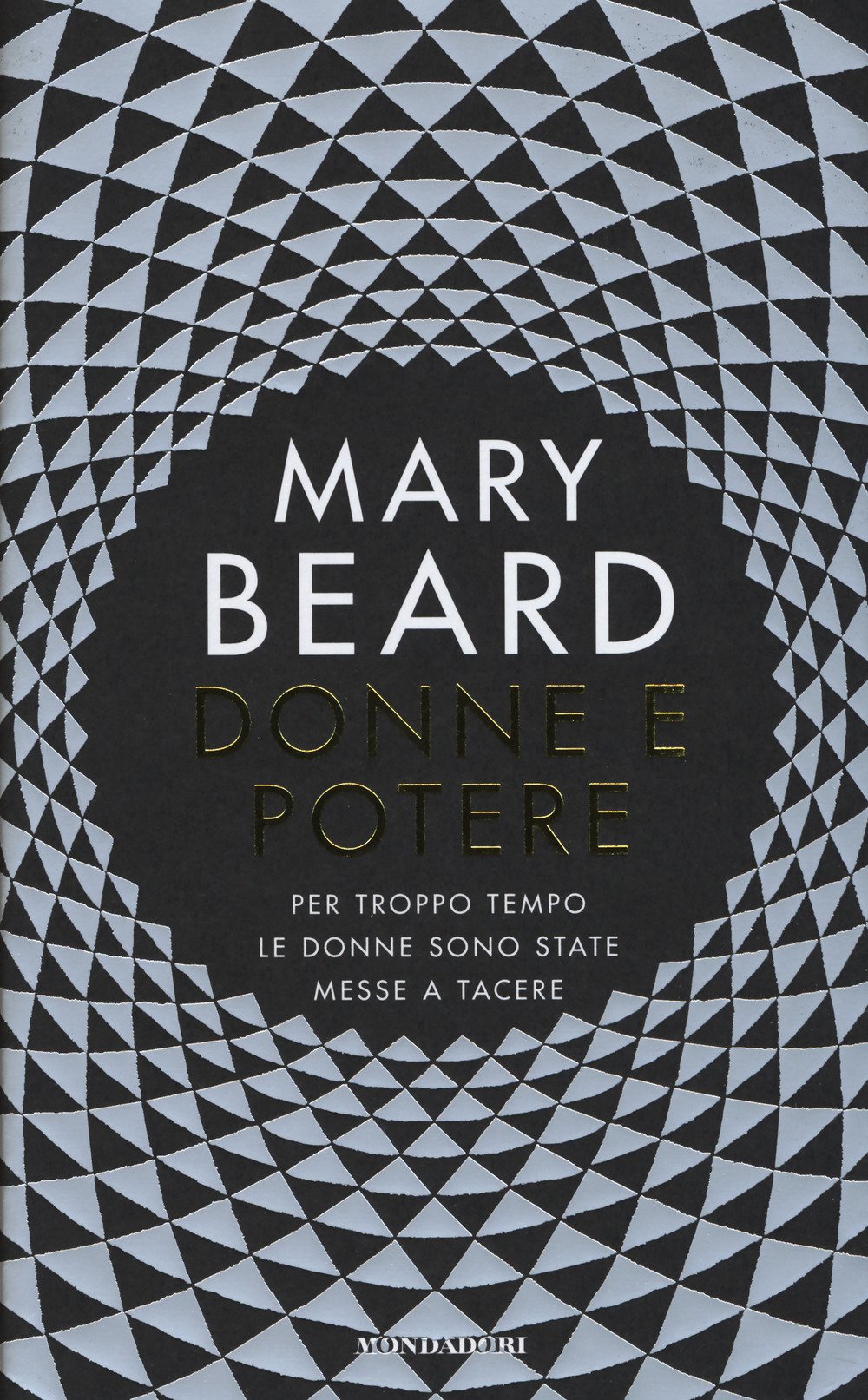In Donne e potere, Mary Beard – classicista di fama internazionale, professore al Newnham College di Cambridge, editor del Times Literary Supplement, blogger di successo (“A Don’s Life”) e nota documentarista per la BBC – raccoglie due conferenze, dal titolo La voce pubblica delle donne e Donne al potere, tenute rispettivamente nel 2014 (al British Museum) e nel 2017. Nella postfazione dichiara di aver effettuato, nel testo a stampa, qualche lieve ritocco, senza tuttavia intervenire sulla sostanza del discorso. Il risultato sono due testi dalla struttura identica: per illustrare il tema si parte dai testi greco-latini per poi passare all’epoca contemporanea, con particolare riferimento ai discorsi pubblici e alle nuove forme di comunicazione introdotte dai social network. La chiusura è affidata ad una proposta operativa relativa alla questione affrontata.
All’inizio del primo scritto è ricordato l’episodio dell’Odissea in cui l’adolescente Telemaco mette a tacere la madre, che aveva osato chiedere all’aedo di intonare un canto meno triste: la parola (il mythos) non appartiene alle donne ma agli uomini e soprattutto a Telemaco, che è il padrone della casa. Da questo breve dialogo l’autrice trae la seguente conclusione, forse la più interessante dell’intero libro: «Il discorso pubblico e l’oratoria non erano, io credo, semplicemente attività che le donne del mondo antico non svolgevano, ma erano pratiche e abilità esclusive, che definivano la mascolinità in quanto genere».
L’ipotesi è confortata da riferimenti tratti da altri testi antichi. Nelle Ecclesiazousai, la commedia di Aristofane in cui le ateniesi cercano di assumere il potere nella polis, il fallimento dell’impresa è decretato dall’incapacità delle donne di adattare il linguaggio privato all’oratoria maschile. Molte fanciulle delle Metamorfosi ovidiane (Io, Eco, Filomela) vengono ridotte al mutismo con una variegata serie di espedienti: il pericolo della presa di parola da parte delle donne non consiste in quello che dicono, ma semplicemente nel fatto che parlino. Se non sorprende più di tanto il fatto che Valerio Massimo affermi che Afrania quando parlava in tribunale “latrava” o “guaiva”, ben più scioccanti risultano alcune perle di saggezza tratte dagli scritti di Henry James, il quale si esprime in modo analogo (se non peggiore) all’antologista del I secolo dell’era moderna. In questa continuità nelle strategie di riduzione delle donne al silenzio e nella disumanizzazione delle loro voci («un borbottio, un’accozzaglia indistinta, una poltiglia, oppure un latrato o un guaito» che somigliano al «muggito della mucca, al raglio dell’asino o il ringhio del cane» – sempre parole di James), l’autrice inquadra gli insulti che le donne che parlano sono ancora costrette a subire, tanto nei consessi pubblici quanto sui social network: i “piagnistei” o i “piagnucolii” di cui sono spesso accusate non hanno altro obiettivo se non quello di svilire, banalizzare e «riprivatizzare» la parola femminile. Per questa ragione, ignorare tali aggressioni nella speranza che si esauriscano spontaneamente, dunque tacere, otterrebbe esattamente l’effetto desiderato da chi le perpetra; la proposta di Beard va nella direzione opposta e prevede inoltre una messa in discussione di ciò che si intende per autorevolezza del discorso, dal momento che l’attuale concezione del termine, oltre che palesemente iniqua, è anche completamente antitetica al pensiero razionale tanto caro all’universo maschile.
Proprio l’autorevolezza può essere considerata l’anello di congiunzione con il secondo scritto, che si apre con un richiamo a Herland, romanzo scritto da Charlotte Perkins Gilman nel 1915: in un remoto angolo del pianeta le donne costruiscono una società ideale senza però rendersene conto al punto che, quando entrano per la prima volta in contatto con degli uomini, la loro deferenza nei confronti delle competenze e delle abilità maschili mette in pericolo la loro creatura. Il romanzo costituisce il punto di partenza per una riflessione sul potere e, più esattamente, sui modelli femminili di potere. Questa volta l’autrice si muove a ritroso, partendo dalle immagini di donne potenti della contemporaneità, pericolosamente simili a uomini se non altro nell’abbigliamento (nel libro c’è una foto di Angela Merkel e Hillary Clinton che si abbracciano in tailleur pantalone), per tornare al teatro ateniese. Clitemnestra – definita androboulon, ‘colei che desidera come un uomo’ -, Antigone, Medea sono sempre usurpatrici di potere; coloro che le contrastano le descrivono immancabilmente come ibridi mostruosi piuttosto che donne. Il loro tentativo di prendere o ridefinire il potere crea disordine e deve essere represso in modo da legittimare ancora il potere maschile.
In una concezione del potere e dell’autorevolezza così irrigiditi le donne non possono che essere sempre delle outsider. Non stupisce così che May, Merkel, Roussef e Clinton siano accomunate dal fatto di essere state raffigurate con la testa di Medusa, la bellissima fanciulla trasformata da Atena in orribile gorgone per il fatto di essere stata violentata da Zeus nel tempio della dea (da notare anche in questo caso la logica stringente). Clinton, in particolare, è finita decollata da un Perseo con il volto di Trump in una contraffazione iconografica del gruppo scultoreo di Cellini, non propriamente artistica ma economicamente redditizia – dal momento che è stata riprodotta su magliette e gadget vari. È sufficiente per le donne che vogliono avere accesso al potere riappropriarsi di simboli che di solito le depotenziano, come la famigerata borsetta di Margaret Thatcher o la stessa figura di Medusa da parte delle femministe? La risposta dall’autrice è negativa: «se la percezione è che le donne non appartengono a pieno diritto alle strutture del potere, non è forse il caso di ridefinire il potere, e non le donne?». Occorrerebbe «concepire il potere come un attributo, o addirittura un verbo, non come un possesso» e «separarlo dal prestigio pubblico»: l’esempio recente sono le tre fondatrici dell’influente movimento – e creatrici dell’hashtag – Black Lives Matter che in pochi conoscono ma che hanno avuto un notevole impatto sociale. Mi sembra che quest’ultimo punto, pur rilevando l’importante connessione tra potere e notorietà, non colga del tutto nel segno; anche ammesso che quanto auspicato da Beard sia possibile – in una società dove la notorietà è sempre più sinonimo di potere – è davvero sul prestigio pubblico in sé che occorre intervenire o non piuttosto sulla sua natura egemonica, esclusiva, personalistica? Più persuasivo è l’invito a «ragionare in modo collaborativo sul potere dei seguaci e non soltanto dei leader», come in sostanza ha invitato a fare anche Michelle Obama in un recentissimo intervento allo United States of Women Summit; e sarebbe opportuno che le donne dessero sistematicamente per scontata l’autorevolezza delle proprie parole, senza pensare di dover dimostrare qualcosa a qualcuno che quelle parole tenta di cancellare senza alcun procedimento razionale o dimostrativo.
Valentina Russi in in DWF (117-118) Palestina. Femminismi e Resistenza, 1-2, 2018