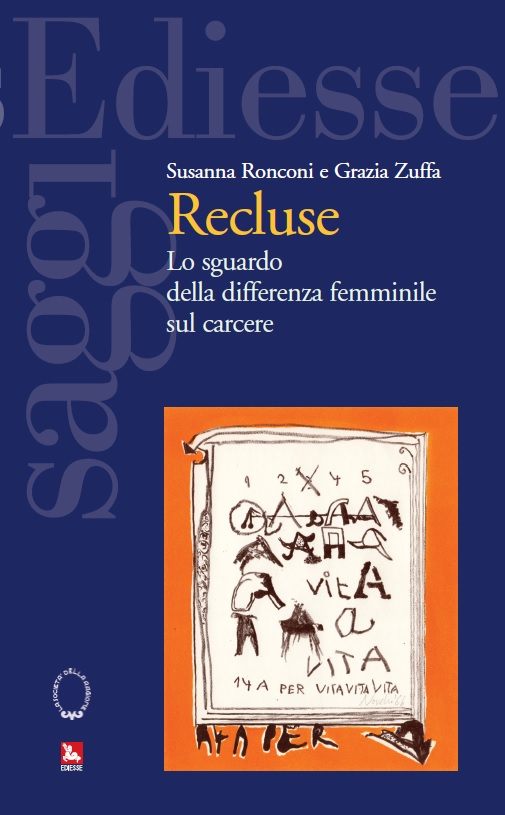Il volume, con una prefazione di Stefano Anastasia ed una postfzione di Franco Corleone, è il frutto della collaborazione fra la casa editrice e la Società della Ragione, un’associazione che promuove analisi sulle condizioni di vita in carcere al fine di diffondere una cultura della pena che preveda il rispetto delle garanzie costituzionali, nell’ottica di un diritto penale garante dei principi di umanità e rispetto della persona.
Il libro, che sceglie la prospettiva della differenza sessuale per leggere la realtà delle donne in carcere, prende spunto da una ricerca svolta nel 2013 attraverso interviste a trentotto donne recluse nei penitenziari di Firenze Sollicciano, Pisa ed Empoli, a tre impiegati come personale educativo e a otto agenti di polizia penitenziaria. Approccio, metodologia e numeri della ricerca sono documentati da una ricca Appendice a cura di Serena Franchi. Obiettivo della ricerca è creare un “intervento preventivo di contenimento della sofferenza e di promozione della salute”, per prevenire atti di autolesionismo e di suicidio in carcere – come spiega Stefano Anastasia nella Prefazione (p. 11).
I sette capitoli del testo – scritti a due mani dalle autrici e ricchi di materiale autobiografico che riporta, attraverso le parole delle intervistate, i vissuti drammatici della detenzione carceraria – disegnano la realtà della vita in reclusione negli istituti carcerari oggetto della ricerca: la pena e le modalità attraverso le quali essa viene scontata sono analizzate con sguardi diversi. I primi tre capitoli riportano il vissuto delle donne recluse: si comincia dalla Percezione femminile dei dispositivi della detenzione (capitolo primo), per passare ad indicare La forza delle donne. Fattori e strategie di coping (capitolo secondo), in vista di una riflessione su Apprendimenti, riflessioni e immagini del futuro prossimo (capitolo terzo). I capitoli dal quarto al sesto, invece, introducono lo sguardo di operatori e operatrici del carcere (personale educativo e agenti di polizia penitenziaria): vengono qui messi in evidenza i meccanismi di protezione e di insofferenza che le recluse mostrano verso il personale carcerario, l’importanza della presenza di supporto fisico e psicologico (con relative proposte di innovazione rispetto agli standard carenti che l’istituizione carceraria propone) e viene posto il difficile problema degli atti di autolesionismo, che possono sfociare nel tentativo estremo di suicidio che può essere prevenuto solo attraverso il miglioramento delle condizioni di vita negli istituti penitenziari, poiché sono proprio le “variabili ambientali e situazionali” a favorire “atti di autoaggressione” (p. 195). I racconti delle donne mostrano il dolore e le durissime condizioni cui costringe la vita in carcere e mettono in evidenza l’assurdità di comportamenti autolesionisti tesi solo ed esclusivamente a ricevere attenzione da parte del personale educativo o della direzione del carcere: «una tattica per incontrare una figura istituzionale […] gesti che si correlano alla descritta dimensione dell’attesa e della mancanza di interlocuzione» (p. 201). La dimensione dell’attesa e della mancanza di risposte caratterizza la vita in carcere e porta a vivere in una dimensione di “minorazione” conseguente allo stato di bisogno totale in cui sono lasciate le detenute, costrette a compilare “domandine” su “domandine” per ricevere risposte a bisogni essenziali e/o a diritti a lungo negati a causa di incertezze burocratiche (una telefonata, un colloquio con i familiari, l’incontro con il personale medico o gli assistenti sociali).
Il settimo ed ultimo capitolo del libro – Il filo della differenza, fra il «dentro» e il «fuori» – è una conversazione delle autrici con Maria Luisa Boccia: in esso si approfondisce un tema che fa da filo conduttore a tutto il lavoro – lo «sguardo della differenza femminile» (p. 239), appunto – messo qui in relazione con le difficoltà di connettere la vita delle recluse fra le mura del carcere (il «dentro») a quella che è la vita delle stesse donne «fuori» del carcere, caratterizzata da peculiarità e da necessità femminili (legami familiari, maternità, cura del corpo). Boccia sottolinea un problema che emerge in maniera pressante anche dalle parole delle intervistate e che parte dalla domanda: “Come posso rimanere me stessa?”. Si tratta della “fatica di restare se stessa” (p. 240) che può essere contrastata – secondo l’autrice – solo facendo lo sforzo di superare la tendenza femminile alla cura dell’altro e concentrando le proprie forze sulla cura di se stesse (del proprio corpo ma anche della propria cella). E qui si innesta un discorso essenziale sul senso e sulle possibilità della cura intesa come affidamento, attenzione e responsabilità verso l’altro. È il ruolo che svolgono le assistenti carcerarie e il personale educativo e che, spesso, può essere ambivalente: ad esso si associa, infatti, sia la positività della presa in carico e del supporto fisico e psicologico, sia la negatività del controllo. Si tratta di un’ambivalenza che rimane irrisolta, nei discorsi del personale carcerario: «I detenuti non tanto facilmente si fidano degli operatori: noi siamo l’istituzione, rappresentiamo l’istituzione con tutti i limiti più che i vantaggi che questo può rappresentare ai loro occhi» (p. 177); e nelle parole delle detenute: «le assistenti […]mi stanno vicino, cercano nel loro piccolo di darmi una mano perché capiscono la situazione. Ci sono stati dei momenti che veramente pensavo di non farcela. Ce l’ho fatta grazie alle assistenti» (p. 105).
La conversazione con Maria Luisa Boccia si conclude con una riflessione sul tema del materno – elemento centrale di tutta la ricerca – nelle sue diverse sfaccettature: dal dolore per i figli lasciati a casa, alle paure per il futuro degli stessi figli, alle relazioni materne che si instaurano fra detenute e con le agenti. Le autrici sottolineano come le parole delle intervistate siano intrise di una retorica del materno acuita, forse, proprio dall’impossibilità di esercitare il ruolo materno determinata dalla reclusione: «Io ora lei la posso vedere solo una volta al mese. Quindi immaginati; è stato un trauma perché mia figlia era la mia simbiosi. È stato traumatico per lei e per me. Io non riuscivo a vedere bambini e a tutt’oggi non posso vedere bambini; se vedo una detenuta con un bambino dico “per favore stammi lontano”, proprio non ce la faccio» (p. 60). Le detenute descrivono l’arrivo in carcere come segnato da una serie di rituali di spersonalizzazione (l’ufficio in cui assegnano la matricola, la consegna di oggetti personali quali vestiti e gioielli, la perquisizione, l’arrivo nelle celle sporche e sovraffollate), ma ciò che colpisce di più è proprio l’enfasi sull’interruzione violenta e brusca dei legami familiari, soprattutto quelli con i figli: «Quindi tu entri qua, strappata dalla tua famiglia, hai lasciato la bambina in braccio a tua sorella, stai vivendo un incubo» (p. 47). Boccia sottolinea come le detenute appartengano alla categoria delle «madri imperfette», intesa come opposta a quella di «buona madre» (p. 258): la rieducazione della pena è tesa a ricondurre la donna alla normalità, dunque a fare di essa una «buona madre». Naturalmente, si tratta di un assunto da interpretare in maniera critica in quanto la «buona madre» non esiste in assoluto e, in particolare fra le mura dell’istituzione carceraria, questa è una figura dietro la quale si nasconde il senso di inadeguatezza e l’allontanamento dalla norma sociale, intesa non solo come incapacità o impossibilità di esercitare il ruolo materno, ma anche come infrazione della legge: «Se non avessi figli…mi farei la galera così, come fosse una passeggiata» (p. 224), spiega una detenuta.
La Postfazione di Franco Corleone, Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, si interroga sulle Zone d’ombra. Quali garanzie e diritti nel carcere femminile: dopo aver delineato alcuni passaggi legislativi che riguardano la questione delle condizioni carcerarie (in particolare un pronunciamento della Corte Europea del gannaio 2013, che condanna l’Italia per «trattamenti disumani e degradanti in relazione al malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano», p. 264), l’autore si sofferma sulla peculiarità delle strutture di pena femminili che definisce, appunto, “zone d’ombra” in quanto spesso luoghi nascosti e appartati di istituzioni maschili, affidati a gestione separata da parte delle suore fino al 1975. La vita delle recluse è caratterizzata da diversi fattori che ne determinano la differenza rispetto alla condizione della detenzione maschile: innanzitutto un atteggiamento di radicalità e di convinzione nel denunciare il malfunzionamento dell’istituzione; poi la condizione delle detenute-madri, che vivono con i figli nel Nido interno al carcere fino ai tre anni di vita del bambino per poi subire il trauma dell’allontanamento e della separazione; infine le difficoltà della condizione transessuale e l’obbligo della divisione fra i sessi anche in occasioni ludiche e ricreative o nella frequenza ai corsi scolastici. Corleone riprende gli obiettivi principali di questa ricerca (un approccio “minimo” e umano al diritto penale, la costruzione di strutture preventive) per presentare il suo percorso di “progettazione partecipata” e “riqualificazione di spazi pubblici”: si tratta di trasformare gli spazi della detenzione – chiusi, separati, meri contenitori di corpi – in luoghi aperti e finalizzati all’incontro comunitario, in cui possano svilupparsi liberamente rapporti di collaborazione «finalizzati a favorire forme di autoeducazione» (p. 271). Tutto questo dovrebbe partire proprio da quei luoghi di subalternità estrema, segnata dalla differenza sessuale, che sono le carceri femminili.
Mariagabriella di Giacomo in DWF (103-104) Tutta salute!, 2014, 2-4