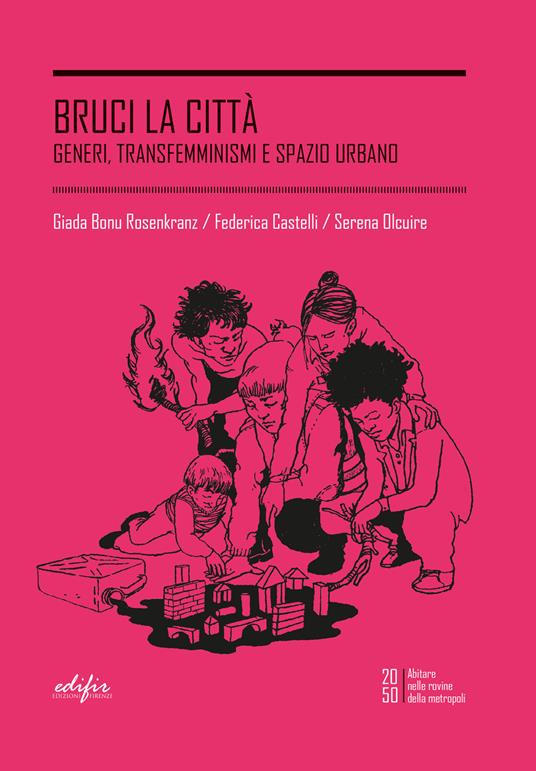Mi sveglio, circondata dalle mura domestiche. Uscendo in strada, vengo trafitta da sguardi che mescolano ribrezzo e disapprovazione. Coprendomi, prendo la metro: ho paura. Entro nell’università, attraverso il corridoio, respiro. Vado a ballare in un locale considerato safe: mani viscide mi toccano senza il mio consenso, forti del privilegio che la società ha conferito loro. Mentre torno alla macchina, mi lanciano una bottiglia. Faccio sesso in un parco, all’aperto. Incontro l* mi* compagn* al centro sociale: ci accogliamo, curiamo le ferite e nutriamo i desideri; facciamo autocoscienza; organizziamo una passeggiata transfemminista. Continuo, come tutt*, a fare esperienza di spazi eterogenei: lo spazio interiore, lo spazio domestico, lo spazio della scuola, lo spazio universitario, lo spazio della clinica, lo spazio lavorativo, lo spazio del centro sociale, e lo spazio urbano che li contiene.
Proprio su quest’ultimo si concentra Bruci la città, che, intrecciando filosofia politica, urbanistica e sociologia all’interno di una prospettiva transfemminista che non si esaurisce nel dichiararsi, pone al centro della propria analisi il nesso che lega le realtà
urbane – la loro progettazione, la logica che le attraversa, le prassi sedimentate in esse – alla dimensione del genere.
La premessa è che non facciamo che abitare spazi, fisici, e, al contempo, immateriali – spazio è anche quell’intreccio di pensieri, parole e affetti che scaturisce dall’incontro fra noi –; spazi che ci impongono la loro storia, ma che, al contempo, investiamo di significati affettivi. Dimensione fondamentale non di una presunta natura umana, bensì della condizione umana, lo spazio, presupposto e prodotto delle stesse relazioni corporee, ci interroga su quanto i luoghi che abitiamo ci condizionino, dirigendo i nostri processi di soggettivazione, limitando e disciplinando le possibilità di azione, espressione e relazione; ma, allo stesso tempo, sul potere trasformativo che può originarsi da un’alleanza fra corpi volta a generare modalità di esistenza alternative e maggiormente vivibili.
Lungi dall’accogliere indiscriminatamente tutti i corpi, infatti, lo spazio – e, segnatamente, quello urbano – si rivela un’ulteriore matrice alla base della loro gerarchizzazione, condizionandone l’accesso e la mobilità – ma anche la collocazione e il conseguente trattamento sociale – sulla scorta di tratti come il sesso, il genere, l’orientamento, l’etnia, la neurotipicità, il tipo di sviluppo, il peso, e perfino il cosiddetto «decoro».
Questo perché nessuno spazio è neutro: concepito da e progettato per un presunto soggetto universale – il maschio bianco eterosessuale cisgender neurotipico e ricco –, ne riflette i desideri, facilitandone l’attraversamento, reiterandone i privilegi di accesso e uso, e dunque il potere (di disporne a proprio piacimento). Nonostante i dispositivi di controllo e disciplinamento dispiegati allo scopo di corroborare la colonizzazione ciseteropatriarcale, razzista e classista dello spazio risultino vari ed eterogenei, ciò che li accomuna sembra essere l’obiettivo di negare alle soggettività inferiorizzate il diritto alla creazione attiva e alla gestione degli ambienti di vita, non solo relegandole in una marginalità materiale e simbolica – e, talvolta, eliminandole –, ma anche favorendo un’atomizzazione disgregante delle alleanze affettive e politiche che sono alla base della reale sicurezza. Si tratta, infatti, di soggettività che, se occupassero visibilmente lo spazio esibendo forme di esistenza alternative rispetto alla norma(lità), avrebbero il potere di scalfirne la logica – come nel caso delle sex workers, moderne streghe che contravvengono all’ideale maschile di femminilità basato su maternità, vita domestica e lavoro di cura non retribuito. Se lo spazio urbano che abitiamo sembra seguire i dettami di un’urbanistica che condanna alla subalternità, all’invisibilità o al misconoscimento tutte le soggettività la cui alterità risulta indigeribile – sebbene funzionale alla riproduzione della gerarchia
sociale ed economica vigente –, allora occorre decolonizzarlo attraverso la messa in campo delle esperienze alternative dello spazio agite dalle soggettività minoritarie. È ciò che aiuta a fare il testo, ripercorrendo quelle prassi di decostruzione e svelamento che, basandosi sulle concrete esperienze di rivolta delle soggettività incarnate – come anche sulle «micro-pratiche» quotidiane di chi non possiede il privilegio temporale della militanza –, sono già costruzione del nuovo.
Fra le pratiche contro-egemoniche valorizzate dalle autrici, un ruolo di primo piano viene assegnato all’occupazione o – per dirla con Louise Michel, scompaginando la distinzione fra privato e pubblico a favore della ben più feconda categoria del comune – a tutte le eterogenee forme di presa di possesso degli spazi urbani in disuso. Contro l’accesso vincolato al consumo proprio della città neoliberale, gli spazi sociali transfemministi si configurano come luoghi in cui viene posta nuovamente al centro la relazionalità, così come i bisogni (ma anche i desideri) delle soggettività che li attraversano e se ne prendono cura. Oltre al carattere politico del gesto consistente nel sottrarre interi edifici e costruzioni a uno stato di sterile abbandono, politica risulta essere anche l’implementazione, al loro interno, di pratiche assembleari volte alla realizzazione di un’auto organizzazione non gerarchica e orizzontale, e dunque alla creazione di modi di vita relazionali e affettivi più liberi.
Ponendo come orizzonte il soddisfacimento dei desideri e della richiesta di socialità di una collettività a detrimento della brama di profitto del privato, l’intreccio fra i transfemminismi e i movimenti per il diritto all’abitare permette poi la creazione di ambienti che, oltre a divenire l’ultimo baluardo contro la turistificazione, la gentrificazione e la precarietà materiale che il capitalismo nella versione neoliberista reca con sé, nelle loro forme più virtuose si presentano anche come laboratori di un abitare collettivo articolato in nuclei differenti rispetto alla cosiddetta famiglia nucleare e imperniato su pratiche di collettivizzazione della cura. Si tratta di laboratori – sempre conflittuali, in quanto relazionali – che, talvolta, si trovano nella necessità di intavolare eterne trattative con le istituzioni al fine di ottenere una qualche forma di riconoscimento rispetto alla quale il potere statuale, che pure le sfrutta per colmare le proprie carenze welfaristiche, oppone il proprio rifiuto – tributare un riconoscimento, infatti, significherebbe ammettere il valore di una logica radicalmente altra.
Quale che sia la forma di opposizione all’organizzazione fallocratica delle nostre città – dall’attacchinaggio alle pratiche di messa in comune, passando per i cortei, le passeggiate e le performance –, dirimente risulta essere, nella visione veicolata dalle autrici, la mobilitazione della dimensione affettiva, capace di rimescolare quella separazione normativa fra privato e pubblico della quale si è spesso avvantaggiato il ciseteropatriarcato, nonché di produrre risemantizzazioni dell’immaginario sociale. «Bruci la città/ e crolli il grattacielo/ rimani tu da solo/ nudo sul mio letto/ […] muoia quello che è altro da noi due». Così scriveva Bianconi in quella che sarebbe diventata un’iconica canzone di Irene Grandi. Ciò che del testo colpisce, però, è come una dimensione così vitalizzante come l’amore venga concepita, in qualche modo, come contrapposta al pubblico in senso lato: affinché l’amore possa alimentarsi, occorre isolarsi, sottrarsi allo spazio pubblico e alle sue norme, rinchiudersi nel privato. Rimaniamo sol? io e te, mentre il mondo esterno con le sue storture va finalmente in frantumi.
Una tentazione comprensibile, ma soltanto il privilegio di chi lo spazio lo può attraversare aproblematicamente può condurre a una tale «romantica» conclusione. Non certo quello delle donne costrette nell’isolamento sociale e al lavoro di cura non retribuito dello spazio domestico, non quello di coloro che lavorano in ambienti vessanti e machisti; non quello delle donne trans costantemente eroticizzate, o dell* sex workers costrett* nei luoghi sempre più pericolosi in cui vengono ipocritamente
confinat*. Non quello dei corpi razzializzati, grassi o divergenti che incontrano ostacoli e discriminazioni a ogni movimento; o quello dell* giovani non-binary, per l* quali troppo spesso lo spazio domestico assume le sembianze di una gabbia soffocante dalla quale, se non cacciat*, sono obbligat* a scappare alla ricerca di reti affettive accoglienti.
Ciò che le autrici propongono è l’attuazione di una logica opposta: è dall’azione dei nostri corpi animati da affetti che, proprio in virtù del loro volersi fare ed esprimere nel mondo, può scaturire una radicale trasformazione degli spazi che abitiamo, e persino la costruzione di nuovi. E allora bruci la città del fuoco transfemminista, affinché dalle ceneri del ciseteropatriarcato con i suoi impedimenti materiali e simbolici possa nascere una nuova città, perché non ci accontenteremo di una stanza tutta per noi.
Mia Rulli in MITICA! Percorsi in relazione in memoria di Paola Masi