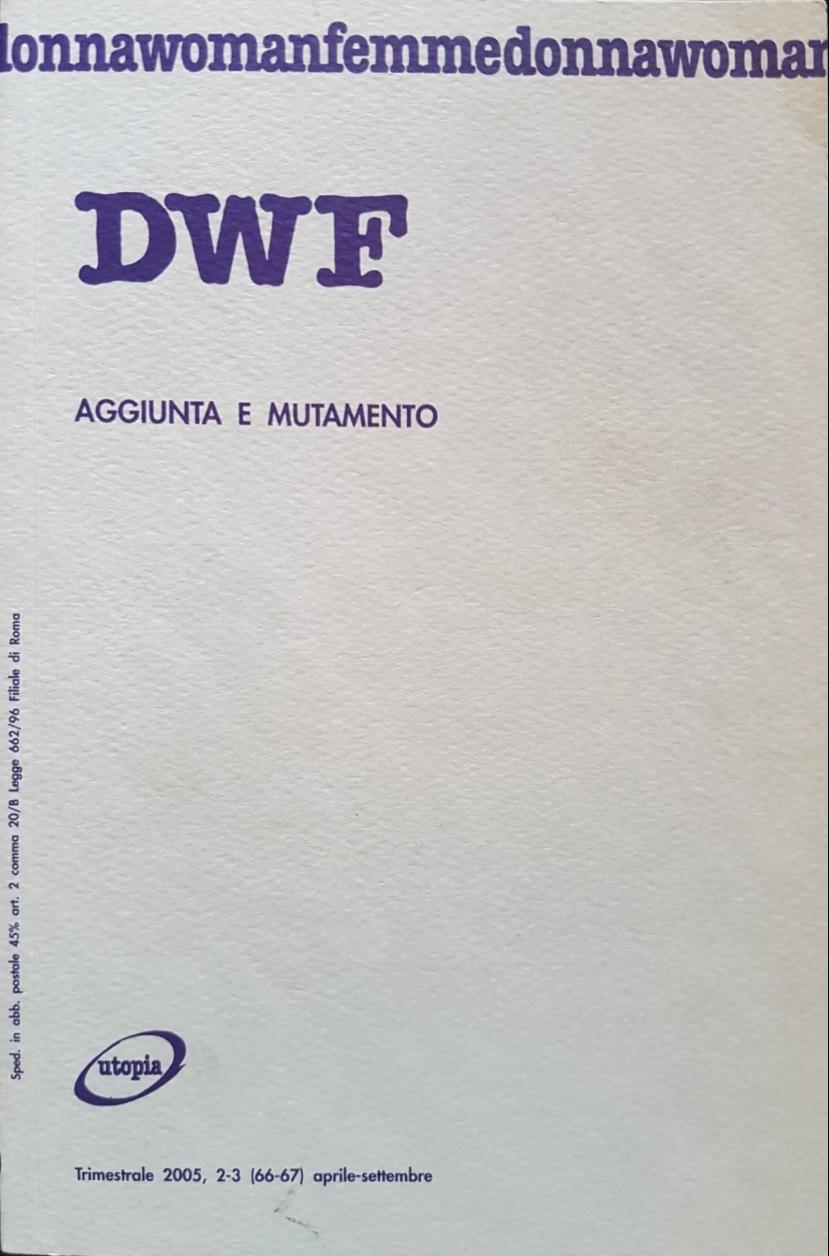Parliamo di una sfida che l’arte porta alla politica. Per essere più precise facciamo riferimento al fatto che da un po’ di tempo, di fronte alla sempre minore efficacia della parola politica, alcune e alcuni artisti riescono a comunicare ed esprimere il bisogno di senso e di cambiamento del mondo in modo molto efficace, aprendo all’ascolto e allo scambio. Cosa questa che era tipica del «parlare del mondo a partire da sé» e che ha segnato il modo di fare e intendere la politica delle donne. Non stiamo però parlando dell’arte come «impegno politico-ideologico », né del ruolo che le avanguardie artistiche hanno o possono avere nella società, rispetto alla politica. Non sono a tema i film di Michael Moore, né i concerti degli U2, e nemmeno le libertà della letteratura o di qualsiasi altra arte rispetto al pensiero politico. Abbiamo piuttosto presente gli scritti di Arundhati Roy sulla globalizzazione e l’impero, i video di Bill Viola sul tempo e sugli spazi, il corpo di Uma Thurman in «Kill Bill», gli spettacoli di Pina Bausch. Questi esempi hanno in comune una forza nell’indicare con precisione, nell’esprimere e dunque nel comunicare il mondo in cui viviamo. Una forza che è stata quella della politica del femminismo. Iniziamo ad interrogare questo fatto: come, dove e perché accade oggi? Il contesto da cui partiamo: la guerra come «politica con altri mezzi» che ci capita di vivere sempre più spesso; e il terrorismo, i rapimenti politici, i conflitti tra etnie, la mercificazione della democrazia. Succede che la comunicazione politica su questi eventi tenda a colpirci individualmente, neanche più come cittadine/i, ma – solo – come corpi e pensieri separati, isolati. Essere ferite/i individualmente: è dolore che colpisce «uno ad uno», non lutto ma solo implosione nell’intimo di ognuno/a, nel ventre molle del privato. Il messaggio sugli eventi del mondo tende a tramortirci. Essere tramortite dal dolore, per la morte, per la minaccia, per la paura e per i teoremi sulla paura: la strategia di controllo riduce il mio essere, il mondo, il nemico, il gene, il byte, a elemento isolato e dolente. Costringe ogni donna a immergersi – e a rimanere – nelle acque che il potere ignora o che non vuole chiamare politica. È, può essere, un bene? Se questo è il contesto può non essere un caso che qualche linguaggio artistico arrivi oggi dove altri non sanno, abbia una forza radicale e agisca per il cambiamento. L’arte è prima di tutto una pratica, la ricerca effettiva di un linguaggio efficace. La sua capacità espressiva mostra nei fatti lo «splendore di avere un linguaggio» di cui parlava Clarice Lispector e che tanto ha significato per la politica delle donne. Ci rimanda a un dire la verità del mondo in cui viviamo, un dire che ritrova corpo, fisicità, materialità e che è capace di ospitare l’accadere, con dolore ma anche con meraviglia. L’arte può aiutare ad elaborare il dolore, a farne lutto, a superarlo come anche ad alzare la soglia dell’insopportabile. Ma resta pratica legata necessariamente alla relazione con l’altra/o che ne fruisce, a cui domanda di un «ritorno»: chiede di accoglierla, di darle spazio e non solo d’interpretarla. Abbiamo provato a rintracciare i segni dell’agire politico che oggi ci piace. Nella desolazione del panorama politico contemporaneo, non possiamo non notare che le poche esperienze che ci sono venute in mente portavano la voce e l’esperienza di chi fa/lavora con il linguaggio artistico: è l’esperienza della «carovana civile» di Fatima Mernissi, è la commissione della verità e della riconciliazione raccontata e documentata da poeti e scrittrici in Sudafrica, è la resistenza attiva contro la costruzione delle dighe in India raccontata da Arundhati Roy. Queste pratiche oggi ci parlano di più di altre. Spezzano il senso d’impotenza e di avversione per questo mondo attraverso un nuovo rapporto tra segni e «stato delle cose». Parlarne è un modo per rilanciare l’agire politico che ci piace, è una forma di responsabilità politica.
Cosa hanno in più, o cosa conservano alcune pratiche artistiche, rispetto alle pratiche politiche della nostra polis? Il bellissimo testo di Ortese ad introduzione de Il porto di Toledo (Adelphi 1998), «Anne, le aggiunte e il mutamento» mostra, crudamente, che quello che ci manca è, non tanto l’individuazione di nuove pratiche – come lo sono state l’autocoscienza, le relazioni tra donne –, perché queste ci sono, sono numerose, le possiamo anche raccontare. Quel che manca è saper individuare, e dunque nominare, cosa faccia di una pratica un «reato di aggiunta e mutamento», appunto, contro un blocco sociale e culturale, contro quella disumanizzazione che, se per Ortese è la riduzione e sopraffazione dell’umano alla «non-ragione», per noi è la miseria che schiaccia le singolarità in individualità – i cittadini in sudditi – rendendole incapaci di autorappresentazione e di «mondificazione». Perché non resti un urlo, una pratica deve rivelare, come già l’arte in certi casi, la sua forza. Per forza intendiamo un atto costruttivo e non distruttivo (diversamente dalla guerra, dalla violenza), un’aggiunta. Esiste una forza di donna, questa è una novità: forza che una non subisce più o soltanto, forza che non è mimesi di quella maschile. Ma come può essere oggi un pensiero della forza? Forse il piacere che viene dalla forza di certi atti artistici ci ha già messo su una buona pista …
L’utile e la tensione all’espressione
Il fatto nuovo da cui partiamo non tiene in conto la sola capacità di comunicazione della parola/linguaggio artistico, che c’è sempre stata, ma le sollecitazioni che rivolge a noi donne femministe, nelle donne che comunicano politicamente. Lo spostamento è essenziale. Mobilità/dinamica/mutamento nell’arte che ci parla, riscopre elementi fondanti anche della pratica politica del femminismo. In noi risveglia la tensione all’espressione, quella che cerca forme alla rabbia con la potenza della bufera. In noi rimette in movimento e solleva dal suolo ciò che resta (molto) fuori dalle regole del mercato. Continuare, riprendere a comunicare politicamente sta anche nel riconoscere che alcuni linguaggi artistici comunicano in modo forte. Insieme a questa tensione, che starebbe dalla parte del desiderio, c’è anche la percezione di un utile che si dà quando si torni a significare il mondo in modo efficace, a trasformarlo. Molto del concetto di utile è eredità più o meno diretta del settecento europeo e della nascita del capitalismo industriale; vista così sembrerebbe un’eredità pesante; eppure è un concetto che più di altri – insieme a «vantaggio» e «guadagno» – abbiamo largamente usato nel femminismo. La forza di significazione che riconosciamo al linguaggio/parola artistica è anche un’occasione per capire meglio l’utile che ci interessa. «Utile» porta dentro un valore d’uso, un soggetto e un corpo, che lo rendono legittimo, senza abuso, senza troppi fantasmi, utile come utensile quotidiano. L’utile nel corpo a corpo con alcune opere d’arte si misura in felicità, una specie di euforia da accrescimento di realtà e, insieme, da difesa vincente sul potere. Una felicità che arriva per «soprammercato», nelle parole di Cristina Campo, e che rimane sempre fuori dal calcolo. L’utile che sopravviene dimostra come il tempo del mutamento può essere differito o dislocato – talora è la scrittrice a fare aggiunta e la lettrice a fare mutamento – ma che la trasformazione è conseguenza della relazione.
La forza delle cose
La distanza tra arte e politica si accorcia solo se la pratica e il linguaggio che ci riguardano non si limitano all’interpretazione, anzi, battono contro le anestesie e gli occultamenti – e l’insignificanza – che un eccesso d’interpretazione genera. Un linguaggio che abbia la forza di restituire le cose, e i soggetti, a loro stesse/i, capace di sopportare come tale il desiderio d’infinito dell’arte – e il desiderio di felicità racchiuso nella politica – senza svuotarlo, senza riempirlo. Come nel racconto di Anna Banti, Le donne muoiono, dove gli uomini cominciano a credere di avere un futuro infinito e le donne imparano ad usare gli strumenti per lenire e convivere con la consapevolezza e la memoria della propria finitezza.
Fare spazio alle voci senza parola
Il testo di Ortese ripropone il tema della possibilità di far parlare gli esclusi, «quelli che non si salvano nell’Espressione» (p. 14). Ortese scrive per rivolta contro la pianificazione umana e in nome di quelli che – come la Anne, la donna cui è dedicato il libro – vivono la condizione umana come «pioggia e buio», per i quali «il potere della non-ragione cammina sulle teste» (p. 15). È un attacco potente, forte come può esserlo la forza di chi sente su di sé un abuso.Ma è davvero possibile dare voce ai «senza voce»? Sì, ma a due condizioni. La prima è che si abbandoni – come in Deleuze, come nell’«obiezione della donna muta», la pretesa di «rappresentare » o di «parlare per» della politica – e ci si assuma la necessità e il rischio di «ri-presentare» – come nell’arte e nella filosofia. Ortese ci spiega come l’Espressivo – l’arte come pratica e ricerca – sblocca il contesto, non dà spazio ma crea spazio nell’aggiungere e mutare (fa il vuoto?). Nello stesso senso Freud lascia il segno nel pensiero delle donne non perché fa un «passo indietro» rispetto all’insignificabile della sessualità femminile ma perché crea lo spazio in cui possano parlare la poesia e le stesse pazienti. Il fare spazio infatti, ci dice l’esperienza, non sta dalla parte della virtù democratica della tolleranza, ma nell’esserci con la pienezza di un’attenzione intensa. Resta il lavoro, cui qui diamo inizio, di individuare le pratiche politiche di questo atto di creare occasioni di presenza, di presa di parola. La seconda condizione è che gli «esclusi» siano raccontati «da dentro». Si dovrebbe essere capaci – come Arundhati Roy – di aprire spazi per i senza voce, gli oppressi, i sudditi, i senza spazio per la parola ma non senza parole. Il meccanismo funziona solo se si conosce – empatia – la loro condizione. Roy è dentro, sempre dentro la macchina dell’impero; il fatto che ne sia, come tutti, dentro, non le toglie la capacità e la forza di chiedere e immaginare una «giustizia poetica» rispetto agli abusi ripetuti e «normalizzati» in cui è organizzata la polis contemporanea. C’è un’esperienza del dentro/fuori legata al corpo di ogni donna che rende possibile pensare da dentro conoscendo la necessità/verità di ciò che è fuori. Come nell’opera «Barbableu» dove la Bausch duplica con i propri ballerini le mosse e le parole dei cantanti: dentro la scena e fuori il contesto della scena, lasciando che i ballerini cadano per terra ogni tanto, come per spezzare ogni possibile ricomposizione unitaria o unificante della visione.
(Testo elaborato e discusso da Paola Bono, Patrizia Cacioli, Monica Farnetti, Laura Fortini, Federica Giardini, Brunella Greco, Paola Masi, Valentina Russi)